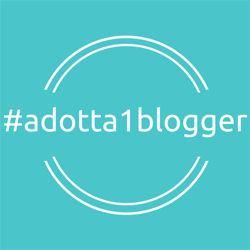Il 22 febbraio del 2010 è stato il giorno più brutto della mia vita perché proprio in quel giorno sono morto.
Mi chiamo Federico e avrò per sempre quattro anni.
Mio papà era il mio eroe. Mi prendeva in braccio e mi faceva volare in alto mentre i miei riccioli biondi splendevano sotto i raggi del sole. Mi faceva salire sulle sue spalle grandi e mi portava a spasso senzamai stancarsi. Guardavo il mondo dall'alto e mi sembrava così magico e pieno di cose interessanti. Dal passeggino non si gustano tutti i colori delle strade. Non si vedono le luci rosse dei negozi né i vestiti variopinti della gente. Ci sono soltanto tante gambe che ti passano davanti, correndo da una parte all'altra. Sulle spalle del mio papà invece, era tutto più bello e vivo. E se volevo girare, bastava che gli tiravo i capelli a destra o a sinistra come le redini del mio cavalluccio a dondolo.
Quando ero più piccolo, con tanta pazienza mi ha insegnato a camminare. Ricordo che avevo paura di poggiare i piedi a terra perché credevo di cadere ma lui, con le sue mani grandi, mi teneva delicatamente e mi aiutava a muovere i miei primi passi incerti. A volte inciampavo o perdevo l’equilibrio ma lui era sempre lì, accanto a me e le sue mani mi afferravano al volo impedendomi di cadere e farmi male.
Con lui giocavo spesso a nascondino e anche se mi nascondevo sempre dietro la porta della cucina, faceva sempre finta di non trovarmi per farmi vincere.
Mi ricordo che un giorno mi ha fatto guidare la macchina nel parcheggio di un grande supermercato. Mi sono seduto sulle sue gambe forti anche se non riuscivo comunque a vedere bene la strada. Mi sono aggrappato con tutte le mie forze allo sterzo e mentre lui faceva camminare in avanti la macchina, io giravo da una parte all'altra suonando il clacson.
Qualche volta mi rimproverava, quando facevo i capricci o quando combinavo qualche guaio. Io lo guardavo con gli occhi tristi perché mi dispiaceva farlo arrabbiare e subito dopo mi sorrideva comprensivo.
Una mattina, mentre giocavo con la palla in cucina, ho fatto cadere a terra il suo telefonino. Si è rotto in tanti pezzi che sono schizzati da tutte le parti. La batteria è finita sotto al divano e addirittura un bottoncino lo abbiamo trovato dentro al lavello. Quella volta papà si è arrabbiato tanto con me anche perché mi aveva detto mille volte di stare attento. Poi però abbiamo fatto pace, come sempre.
La mia mamma era bellissima. Il suo sorriso dolce è stata la prima cosa che ho visto quando sono venuto al mondo. Il suo viso, il suo sguardo, i suoi capelli li conosco talmente bene da poterli vedere in ogni loro piccolo dettaglio appena chiudo gli occhi.
Lei era la ninna nanna che mi faceva addormentare la sera e l’abbraccio forte del buongiorno. Era la soffice schiuma che mi avvolgeva nel bagnetto profumato e la coperta calda dove mi piaceva affondare il viso.
Ricordo quando mi insegnava le lettere dell’alfabeto ed i numeri. Le vocali e i giorni della settimana. Ogni tanto per farle un dispetto, fingevo di dimenticare il venerdì per arrivare svelto alla fine. Lei mi guardava negli occhi con lo sguardo serio e poi cominciavamo a ridere.
Erano bellissimi gli occhi della mia mamma quando rideva. Sembrava che brillassero come tanti pezzetti di quel vetro sui lampadari della nonna che quando il sole li illumina, accendono tanti puntini luminosi in tutta la stanza.
Quando mi teneva in braccio e mi dava il biberon, mi perdevo nel suo sguardo, sicuro di non dover temere nulla. Il suo abbraccio era caldo e così morbido che mi abbandonavo sempre ad un sonno sereno pieno di sogni meravigliosi.
Con la mia mamma ho fatto il mio primo pupazzo di neve mentre papà ci faceva tante fotografie da lontano. Con lei andavo al parco a giocare sull'altalena e sullo scivolo. Spesso pretendevo che venisse con me anche sui giochi riservati ai bambini. Una volta ci siamo divertiti tantissimo saltando per ore sul tappeto elastico in giardino.
Anche lei qualche volta si arrabbiava con me, ma col mio sorriso sono sempre riuscito a strapparle tutte le coccole di cui avevo bisogno. Tutti i baci che volevo.
Mentre papà guidava la macchina, la mia mamma giocava con me sui sedili posteriori. Mi raccontava le favole e mi faceva il solletico. Ballavamo euforici mentre papà ci guardava dallo specchietto e rideva insieme a noi.
Lei era così. Era la mia mamma e anche se in modo diverso, continua a coccolarmi e ad avvolgermi col suo spirito gentile. I suoi occhi brillano ancora ma di una luce diversa, più pura e candida.
La mattina mio papà andava a lavorare presto, mentre ancora io dormivo. Anche se lui non si accorgeva, lo sentivo avvicinarsi in silenzio e baciarmi delicatamente la fronte scostandomi i capelli conla mano. Poi mi riaddormentavo sereno.
Quando mi svegliavo, la mia mamma mi riempiva di baci e mi abbracciava sempre forte forte. Facevamo colazione insieme con i miei biscotti preferiti e poi mi accompagnava a scuola. Per la verità non mi piaceva tanto andare a scuola, avrei preferito andare al parco a giocare o correre sulla spiaggia ma la mamma mi prometteva che sarebbe tornata presto a prendermi. E così faceva sempre.
Quel lunedì faceva freddo. Le strade erano tutte bagnate e piene di pozzanghere ai lati dei marciapiedi. La pioggia cadeva cocciuta fin dal giorno precedente, riversandosi sul vialetto di casa e allagando la mia piccola casetta di legno in giardino. Mi ricordo che il cielo era così grigio che mi sembrava ancora notte. Non c’erano gli uccellini sui fili della luce né i gatti che solitamente stavano nascosti sotto le auto parcheggiate nella via.
Il rumore della pioggia era forte e continuo. Incessante. E dalle finestre che gocciolavano, non riuscivo a vedere altro che un mondo in bianco e nero.
La mamma mi vestì con un maglione di lana rosso sgargiante per ripararmi dal freddo. Sopra un impermeabile, guanti e cappello dello stesso colore del maglione. Il mio colore preferito!
Nel tragitto dal portone alla macchina della mamma, immergevo divertito gli stivali dentro le pozzanghere che si erano formate, schizzando l’acqua dappertutto. La pioggia mi bagnava la faccia nonostante la mamma mi tenesse vicino a sé, sotto un grande ombrello blu che svolazzava ad ogni folata di vento.
Dai finestrini della Yaris di mamma, il cielo aveva lo stesso colore cupo che avevo visto dalle finestre, diverso dal colore rosso che ho sempre amato.
La casa dei miei genitori è lontana dalla mia scuola. E’ lontana anche dall'ufficio di papà e da quello della mamma. Abitavamo in campagna e per raggiungere la maestra ed i miei compagni di classe, ogni mattina dovevamo percorrere parecchia strada. Tante curve e rettilinei di una via stretta e tortuosa.
I tergicristalli si muovevano velocissimi ma l’acqua sembrava non voler andare via. E anche se l’aria condizionata era accesa e regolata al massimo, il parabrezza era tutto appannato.
Per colpa mia, eravamo un po’ in ritardo e la mamma andava più veloce del solito: avevo fatto i capricci durante la colazione e anche quando mi aveva vestito. Nonostante prendessimo quella strada ogni giorno, sotto la coltre grigia della pioggia tutte le curve mi sembravano uguali. L’orizzonte era nascosto da un velo pesante di nebbia dello stesso colore della pioggia e quasi non si vedeva la strada davanti alla macchina, tanta era l’acqua che cadeva e che si era accumulata a terra.
Non ricordo con precisione quello che accadde. All'improvviso l’auto cominciò a girare come una trottola mentre i miei peluche volavano da una parte all'altra. Si sentivano dei rumori forti come se qualcuno stesse prendendo a colpi di martello gli sportelli. Tra le urla della mamma i vetri esplosero uno dopo l’altro coprendo il sedile di minuscole schegge luccicanti e mentre la macchina precipitava dal cavalcavia, cominciai a piangere per la paura. Poi non ricordo più nulla se non un lampo nero e silenzioso.
Dai rottami dell’auto si sollevava un leggero fumo grigio spazzato via dal vento furioso e dalle raffiche di pioggia che cadeva instancabile. Le ruote giravano ancora ma non poggiavano più a terra e dal bordo della strada potevo vedere il fondo della Yaris che ora era rivolto al cielo.
La mamma non piangeva più e neanche io. Eravamo abbracciati l’uno all'altra e guardavamo i nostri corpi a testa in giù all'interno dell’abitacolo. La pioggia non ci bagnava ed il vento non ci infastidiva. Non indossavamo più i vestiti. Né l’impermeabile né i guanti né il cappello. Non avevamo freddo.
Anche se non capivo come fosse possibile, non sentivo dolore né tristezza e anzi riuscivo a percepire l’amore della mia mamma più forte e deciso di prima. Lei mi guardava e mi sorrideva senza parlare anche se io la sentivo nella mia mente. Mi diceva di non preoccuparmi perché lei non mi avrebbe lasciato mai. E come prometteva sempre quando mi accompagnava a scuola, anche allora non venne meno alla sua parola.
Dopo qualche minuto arrivarono tante persone. Riparate dagli ombrelli, scesero dalle auto e vennero a cercarci. In poco tempo ci fu tanta confusione, tante automobili e tanta gente. Arrivò un’ambulanza con le sirene accese e luci blu che si sbiadivano attraverso la nebbia della campagna. Avevo anch'io un modellino di un’ambulanza ma le luci non erano così belle.
Nel luogo dell’incidente arrivarono altre persone ed altre macchine con le luci blu e le sirene. C’era tanto caos e tanto rumore quando da lontano riconobbi l’auto di papà. Correva in mezzo alla pioggia sollevando spruzzi alti di acqua sporca. Quando scese giù non aveva né ombrello né cappello. La pioggia gli colava sul viso ma io sapevo che quelle erano lacrime di tristezza e dolore. Quello stesso dolore che io e la mamma non avvertivamo più.
Si precipitò urlando verso la macchina della mamma ma due signori lo fermarono e lo trattennero con difficoltà. Si dimenava e gridava finché non si inginocchiò a terra continuando a piangere vinto da una sofferenza che gli squarciava il cuore in mille pezzi e nonostante non sentissi più dolore, cominciai a sentirmi tanto triste per il mio papà.
Avrei voluto dirgli di non preoccuparsi perché stavo bene. Avrei voluto tranquillizzarlo dicendogli che con me c’era la mamma e che avrebbe pensato lei a me. Avrei voluto e ci ho provato ma lui non mi sentiva. La mia voce era solo un sospiro in mezzo al frastuono delle sirene e della pioggia. E anche se gli diedi un bacio sulla fronte proprio come faceva lui la mattina, non riuscì ad avvertire il mio calore ed il mio amore.
I giorni seguirono le settimane che si accumularono nei mesi. Superato lo shock del funerale e della sepoltura, papà provò a recuperare i normali ritmi della sua vita ma il vuoto lasciato da me e dalla mamma era troppo grande per essere riempito.
I nonni passavano tanto tempo con lui nonostante cercasse sempre di stare da solo. Lo vedevo passeggiare per casa con tutte le luci spente mentre le lacrime gli rigavano il viso segnato da mille rughe. Spesso lo seguivo mentre si incamminava per i boschi e la campagna e ogni volta che riuscivo a far spuntare un piccolo fiorellino rosso davanti a lui, alzava lo sguardo al cielo e mi sorrideva.
Ogni tanto andava al mare e si sedeva sugli scogli ad ascoltare il suono delle onde. La brezza marina gli scompigliava i capelli che erano diventati più lunghi e più grigi mentre il suo sguardo si perdeva in un punto lontano all'orizzonte.
Il suo cuore era diventato freddo e il sorriso che avevo tanto amato, era scomparso per sempre dal suo volto. Dell’uomo forte ed alto che mi prendeva in braccio e mi faceva volare non era rimasta che un’eco lontana. Le spalle che mi sorreggevano senza alcuna difficoltà adesso sembravano curve e stanche, e quelle braccia che mi afferravano sicure quando muovevo i miei primi passi, adesso sembravano immobili, abbandonate dentro le tasche del giubbotto.
L’angoscia che lo dilaniava era un incendio che non riusciva a spegnere. Che non gli dava tregua. Il senso di solitudine che lo aveva avvolto di un velo nero, lo consumava e lo bruciava come un fiammifero abbandonato in un braciere.
La gioia per la vita che mi aveva trasmesso, la felicità per le piccole cose che mi aveva insegnato ad apprezzare adesso erano celate dietro una barba ispida ed incolta che lo faceva assomigliare più ad uno spettro che non ad un uomo.
Nonostante la difficoltà iniziale, trascorsi un paio di mesi, riprese a lavorare pensando che in qualche modo gli impegni lavorativi potessero sedare l’ansia e la solitudine ma quando la sera rientrava a casa, il silenzio che lo accoglieva cominciava a ronzargli nelle orecchie fino allo sfinimento. Fino alla pazzia.
Ogni angolo della casa era rimasto identico alla mattina in cui io e la mamma siamo andati via. I miei giocattoli erano ancora riversi a terra in un pandemonio di colori e di forme. Le mie macchinine variopinte occupavano ancora le mensole della mia stanza e metà dei ripiani dell’armadio. Persino Totò, il mio peluche preferito, stava ancora accucciato sul mio letto in attesa del mio ritorno.
A dispetto del silenzio che c’era in casa, sia io che la mamma stavamo sempre vicino a papà. Quando lo vedevo davanti al televisore mi sedevo sulle sue gambe e la notte ci stendevamo accanto a lui accarezzandogli i capelli. Stavamo in macchina con lui mentre andava a lavorare e durante le sue passeggiate solitarie al mare, camminavamo al suo fianco come durante le nostre gite domenicali.
La mamma spesso gli poggiava le mani sul viso sperando di essere “sentita” ma il suo cuore stava diventando sempre più duro ed insensibile. Un paio di volte, mentre giocavo nella mia cameretta, ho fatto muovere la palla, ma come succedeva la mattina quando mi baciava, neanche adesso si accorgeva di nulla.
Credevo che quando le persone si amano, si crea tra di loro un legame talmente forte che gli permette di parlarsi anche senza parole. Un filo invisibile che li lega indissolubilmente per tutta la vita. Una sintonia così perfetta capace di far avvertire le sensazioni l’uno dell’altro anche a distanza. Ed invece, per quanto forte potesse essere stato il nostro legame, la morte si è dimostrata più forte e potente, incredibilmente abile nell'assopire la capacità del mio papà di sentire l’amore che, nonostante l’infinita distanza che si era frapposta tra di noi, provavo per lui.
A dispetto dei mesi che si seguivano inesorabili, il dolore di papà non esitava a diminuire. Sempre la stessa solitudine accecante, sempre la stessa lancinante fitta al cuore che gli toglieva il respiro. Giorni da “sopravvivere” nell'attesa di un niente che prima o poi sarebbe arrivato.
Fu in quei giorni di luglio che in preda all'ennesima crisi di pianto, mio papà decise di fare qualcosa di concreto per ritrovarci. Non accettava l’idea di averci perduto per sempre e si era convinto che l’unico modo di trovare un po’ di pace era quello di mettersi alla ricerca di una nostra traccia.
Pensava che le persone che muoiono non posso scomparire dalla terra in uno schiocco di dita ma che una parte della loro essenza deve per forza rimanere invischiata nelle trame misteriose della vita di altri esseri viventi. Il soffio vitale che alimenta ogni uomo che abita su questo mondo non può spegnersi come una candela al primo alito di vento del destino ma deve necessariamente poter ravvivare la fiamma nell'anima di qualche altro individuo.
Era ossessionato da quest’idea e prima che la realtà immobile in cui viveva lo avrebbe stritolato per sempre, mio papà, il mio eroe, si svegliò e con un colpo di reni, reagì.
Mise in vendita la casa che avevano costruito insieme alla mamma mattone dopo mattone. Il nido dove avevano custodito il loro amore e dove, dopo poco tempo, ero nato e cresciuto anch'io. Il posto dove ho imparato a camminare e correre, dove giocavo a nascondino con papà e dove la mamma, con gli occhi pieni di amore, mi cullava per farmi addormentare.
Decise di vendere la macchina che mi piaceva tanto. Quella che ci portava tutti insieme al mare ed in montagna. L’auto con cui sfrecciavamo veloci per strade inesplorate, quella che avevo guidato in un parcheggio di un centro commerciale e che il giorno del nostro incidente, avevo visto arrivare di corsa attraverso il velo grigio della pioggia.
Lasciato il lavoro ed ogni altra cosa che possedeva, papà salutò i nonni che, sebbene non riuscirono a comprendere la sua decisione, si dimostrarono forti pur nella tristezza di un lungo addio. Papà si liberò dei vestiti e dei mobili di casa, delle mille cianfrusaglie che ingombrano ogni appartamento e delle radici che lo tenevano ancora imprigionato alla nostra città come catene.
Tenne con sé soltanto le fedi nuziali che si erano scambiati con la mamma nel giorno del matrimonio e la macchina fotografica con cui avrebbe intrapreso un lungo viaggio alla ricerca di se stesso, mia e della mamma. Uno zaino conteneva tutta la sua vita, le nostre vecchie foto felici, qualche vestito e i soldi che aveva ricavato dalla vendita della sue cose.
E alla fine partì.
Un TIR incrociato lungo una strada provinciale fu il suo primo mezzo di trasporto. L’autista trasportava un carico di alimenti diretti in Campania ma avrebbe dovuto fare numerose altre soste intermedie. All'interno della cabina del camion, in silenzio, oltrepassò lo stretto di Messina e poi, attraverso una campagna arida colorata di giallo, arrivò fino in Puglia. Dopo aver ringraziato l’autista si diresse al porto. Qui un vecchio pescatore dal volto segnato dal sole e dalla salsedine stava insegnando ad un ragazzino come piegare le reti da pesca e riporle all'interno della barca. La luce del sole sullo specchio del mare creava una speciale luce dorata attorno all'imbarcazione e senza quasi rendersene conto, mio papà impugnò la macchina fotografica e scattò la prima fotografia del suo lungo viaggio.
Dal ponte del traghetto che lo avrebbe portato in Albania le creste delle onde sembravano pigre e svogliate. Il mare era una placida distesa blu che veniva squarciata dallo scafo della nave come uno strappo dai bordi irregolari. Attraversò l’entroterra albanese su una vecchia bicicletta acquistata per pochi euro da un giovane dallo sguardo furbo. La campagna aveva gli stessi colori e gli stessi profumi della sua terra. Il cielo le stesse nuvole e la notte gli stessi incubi.
Passarono i giorni ed i chilometri. La campagna albanese divenne quella della Grecia con i suoi colori chiari e vivi. Ad ogni città che attraversava, nuovi occhi e nuovi volti gli si presentavano davanti. Per una colazione e un pranzo, mio papà si offriva di aiutare qualche artigiano in qualche piccola faccenda e non appena una madre col figlio catturavano la sua attenzione, rubava furtivo delle foto dei loro sguardi e dei loro abbracci.
Io e la mamma gli eravamo sempre accanto, lo accompagnavamo lungo la strada avvertendo la sua stanchezza e la sua vorace inquietudine.
La Turchia accolse papà con i suoi colori ed i suoi contrasti. Conobbe la povertà e la felicità che ne era la fedele compagna. Vide bambini dai visi sporchi e sudati, che ridevano gioiosi dai loro occhi blu cobalto. C'erano madri premurose che cullavano piccole creature avvolte da stracci logori e sdruciti. E padri che senza un soldo, lottavano quotidianamente per garantire un tozzo di pane alla propria famiglia.
Mio papà trascorse alcuni giorni in quel posto tanto triste e colorato allo stesso tempo. Dormì in un piccolo deposito di legna di proprietà di un signore gentile da cui ricevette qualcosa da mangiare in cambio di un po' di aiuto nei campi. La sua macchina fotografica catturava i gesti dei ragazzini che giocavano con una palla di pezza in una strada fangosa.
Quelli furono i giorni in cui conobbe una disperazione ed un dolore più forte del suo. Attraversò i territori aspri dell’Iran e dell’Afganistan dove oltre alla povertà, madri e padri disperati, lottavano quotidianamente contro la guerra e la violenza. Contro le bombe e i fucili.
Aveva regalato la sua bicicletta malandata al figlio del panettiere che lo aveva sfamato per un paio di giorni in un piccolo villaggio al sud della Turchia. Adesso viaggiava a piedi lungo strade strette e polverose. Sfruttava i passaggi in groppa ai muli dei contadini che raramente incrociava lungo il suo cammino. Ed ovunque bambini sorridenti, altri in lacrime nascosti negli angoli delle strade deserte ed altri ancora orfani o abbandonati, costretti ad una vita perennemente in lotta per una sopravvivenza amara e vuota.
Io e la mamma eravamo sempre al suo fianco. Passo dopo passo. A volte gli saltellavo attorno inseguendo una farfalla o un alito di vento. Giocavo con quei bimbi sporchi e affamati che abitavano tra i ruderi sopravvissuti alle esplosioni della guerra e spesso, mentre papà faceva le sue fotografie, sorridevo anch'io guardando incuriosito l’obiettivo della fotocamera.
A bordo di auto malconce e di camion in condizioni peggiori, mio padre arrivò lentamente fino alle campagne indiane. Fu molto bello trascorrere in quei luoghi così tanto tempo. La spiritualità della gente ed il suo inspiegabile ottimismo fu come un tonico per l'anima di papà. Se non una giustificazione, trovò una rassegnazione che accettò giorno per giorno. Imparò lentamente ad accettare la nostra scomparsa convincendosi che forse, il compito di chi rimane in vita è quello di mantenere vivo e splendente il ricordo di chi non c'è più.
Furono quelli i giorni in cui il mio papà, il mio eroe, ricominciò a sorridere. Godeva del sole che gli accecava gli occhi mentre arava i campi o portava le pecore al pascolo. Rideva quando la pioggia lo sorprendeva violenta e quando il vento, subito dopo, gli asciugava i vestiti intrisi della polvere accumulata durante il suo viaggio intorno al mondo.
Gli occhi truccati delle donne e delle madri dei villaggi che attraversava, nascondevano pensieri misteriosi e lontani. Le loro mani decorate da fiori di henné cullavano i bambini che si addormentavano con la stessa serenità che mi circondava quando vivevo tranquillo a casa dei miei genitori.
Erano luoghi magnifici ed immensi che papà catturava caparbio. Rubava i loro colori, i loro dettagli che splendevano rilucenti al tocco della luce dorata del sole. Le loro sfumature nascoste e celate dal fango e dalla polvere. Immortalava i gesti delle persone, le carezze delle mamme ed i capricci dei bambini. Ed in ogni fotografia cercava il sorriso della mamma e la luce dei miei occhi.
Durante una notte stellata passata in un ovile nel Bangladesh, sorpresi papà mentre faceva tintinnare le fedi nuziali che teneva appese al collo. La mamma gli stava vicino accarezzandogli il viso mentre un fiorellino rosso apparve poco distante, proprio davanti ai suoi piedi. Papà scoppiò in un pianto silenzioso che non era più colmo di rancore ma di una amara felicità. Poi si addormentò, abbandonandosi finalmente ad un sonno sereno e senza sogni.
Il suo viaggio da vagabondo continuò attraverso i territori ostili della Birmania, del Laos e del Vietnam. La fitta vegetazione nascondeva un’insidia dopo l’altra mentre con estrema fatica proseguiva alla nostra ricerca. Beveva l’acqua dei fiumi e mangiava i frutti degli alberi che incrociava sul suo cammino. Ovunque persone gentili che lo aiutavano nel suo cammino ed altre che lo scansavano sospettose. Ovunque povertà e felicità, ricchezza e disperazione.
Conobbe le donne bellissime dal collo lungo, adorne di rigide collane d’ottone fedeli alle loro antiche tradizioni. Pianse alla vista di altrettante bellissime donne deturpate dall'acido dell’ignoranza e dalla vigliaccheria. Contrasti di una terra che parlava una lingua troppo diversa dalla sua.
Percorse le campagne cinesi senza rendersi conto di quanto lontano si fosse portato dal luogo in cui vivevamo insieme e felici. Così distante dalla casa che adoravamo e dal dolore infinito che gli aveva strappato la voglia di vivere.
Per una ciotola di riso aiutò un anziano signore a riparare la ruota del carretto con cui trasportava il misero raccolto del suo orto. Lo avrebbe portato al villaggio e venduto per pochi yuan necessari alla sopravvivenza della propria famiglia.
Persino l’oceano Pacifico gli regalò numerosi momenti di riflessione in cui, nascosto nella stiva di una nave mercantile cinese, cominciò a pregare il cielo di avere forza sufficiente per portare a compimento il suo viaggio. Sballottato dalla violenza delle alte onde oceaniche, trascorse quasi un mese da clandestino, dormendo in una cassa di legno in assoluta solitudine. L’uomo che lo aveva aiutato dietro un cospicuo compenso, gli portava qualcosa da mangiare una volta al giorno ed un secchio di acqua. Per tutto il resto del tempo, io e la mamma eravamo la sua unica ed invisibile compagnia.
Il sud America lo accolse con gli stessi contrasti che aveva immaginato mentre pianificava la nostra ricerca. Visitò il Perù e la Bolivia in cui uomini dei vestiti variopinti lo accolsero ed aiutarono. A dispetto della sua radicata sfiducia verso la gente, ogni paese che attraversava gli dava una decisa smentita che accendeva, giorno dopo giorno e debole come una fiammella, una fragile fiducia verso un genere umano troppo spesso distratto e perso nei propri piccoli disastri.
Si convinse che dove la vita aveva creato i danni maggiori dei suoi capricci, sbocciavano gli animi più sensibili e generosi. Ed ancora gli sguardi infantili dei miei coetanei lo catturavano e lo rendevano ostaggio. Ancora volti materni ed ancora carezze, baci ed abbracci che rubava a quella quotidianità così distante eppure tanto simile a quella del suo mondo.
Attraversò le distese sconfinate del Brasile. Le sue foreste e i suoi fiumi. Le sue città, i suoi villaggi e la sua povertà. Imparò ad amare i suoi abitanti pieni di gioia ed allegria. I suoi bambini costretti ad una vita di stenti e di delinquenza, di sudore e vitalità.
All'interno di una baracca passò diversi giorni prima di trovare il modo di imbarcarsi su una nave per il tragitto di ritorno. Le lunghissime spiagge soleggiate erano le compagne ideali delle sue passeggiate solitarie. Fu costretto a spostarsi da un villaggio ad un altro, da un garage ad un sottoscala di una palazzina abbandonata prima di trovare un posto nella stiva di una vecchia imbarcazione per il trasporto di legname.
La traversata dell’oceano atlantico fu più rude e violenta della precedente ma fortunatamente più breve. Alloggiava in una piccola cabina dai muri spogli e grigi, aiutando l’equipaggio nelle comuni mansioni di navigazione. Dall'aiuto cuoco al mozzo. Dalla pulizia delle stoviglie e quella dei ponti.
I suoi risparmi stavano cominciando ad esaurirsi anche se tra i rossi tramonti africani non ne avrebbe avuto molto bisogno. Il periodo che trascorse in Africa lo segnò in modo profondo come aveva fatto in precedenza il soggiorno in India. La semplicità della vita che andava avanti lenta e pigra era scandita dal sorgere e dal tramontare del sole. Dalle piogge esigue e dall'avvicendarsi delle stagioni. Si accostò ad una realtà diversa dalla sua concezione di “esistenza”, distante dal suo modo di affrontare la vita che non cercava di piegarla alle proprie esigenze ma ne assecondava gioie e capricci, tumulti e silenzi.
Conobbe una solitudine diversa e più profonda. Una miseria endogena e radicata. E più di ogni altra volta nei giorni interminabili del suo viaggio, conobbe la fame e la sete. La stanchezza e lo sfinimento.
Conobbe uomini magri per la fatica, bambini debilitati dalla fame e donne curvate dalle malattie. E poi li vide tutti ballare davanti ad un falò, aggrappati ad una inconcepibile gioia di vivere tanto forte da stridere come unghia sulla lavagna.
La fotocamera era ancora il suo occhio su questo mondo tanto alieno che lo travolgeva tra le sue trame indecifrabili in un’atmosfera sospesa nel tempo. Ancora sguardi di bimbi dagli occhi neri come l’ebano. Ancora foto di abbracci rubati e nenie tra gli strati spessi dei vestiti vivaci e variegati delle mamme.
Sperduto in un natura selvaggia e maestosa, mio padre percorse ai piedi i deserti popolati dai Tuareg e le savane dei Pigmei e dei Masai. Lo zaino che all'inizio del viaggio conteneva ciò che rimaneva della sua vita, adesso era vuoto e leggero. Vestiti sgualciti e polverosi ed un caricabatteria solare per la fotocamera che teneva sempre stretta tra le mani. Attraversò territori consumati dalle guerre silenziose ed invisibili al resto del mondo. Percorse le distese sconfinate dei paesaggi assolati e silenziosi dei documentari alla televisione.
E ancora conobbe persone. Ancora madri premurose e figli capricciosi.
In una delle ultime notti in Africa, fu aggredito e derubato dei pochi soldi che aveva tenuto da parte per pagare il viaggio di ritorno. Fu picchiato e lasciato tramortito sotto una luna dallo sguardo freddo e distratto. Le costole urlavano di un dolore sottile e feroce ad ogni respiro ma ebbe comunque un fremito di sollievo quando si rese conto che la custodia che conteneva le schede di memoria della fotocamera era caduta durante l’aggressione finendo nascosta sotto ad un cespuglio insieme alla stessa macchina fotografica.
Raggiunta la Tunisia dove gli occhi delle donne nascoste sotto veli ricamati di pudore e gelosia, brillavano di promesse esotiche e misteriose, mio papà dovette vendere la macchina fotografica per riuscire a tornare a casa a bordo di un barcone vecchio e arrugginito. Ancora una volta le onde del mare lo portarono a rinchiudersi tra i suoi pensieri e le sue riflessioni. Aveva percorso tanta strada e tanti chilometri cercando disperatamente una traccia dell’amore che gli era stato strappato in maniera tanto brutale.
Aveva conosciuto tante persone così diverse tra loro eppure così simili nella loro umanità da sembrare fratelli. Tanti colori della pelle, tante espressioni negli occhi scavati dalle sofferenze. Tanto dolore da sentirsi un privilegiato.
Forse fu questa la lezione che apprese al termine del viaggio.
Tornato dai nonni era comunque un uomo diverso, più conscio e consapevole della vita e delle sue mille sfaccettature. Delle sue gioie e delle sue tragedie. Delle sue peregrinazioni e delle sue distanze.
Scaricò sul computer le tante foto scattate durante il suo viaggio. Gli sguardi di tutti quei bambini lo guardavano sorridendo e piangendo. Indifferenti e timidi di fronte all'obiettivo. Le tanti mamme che aveva immortalato, avevano tutte la stessa premura nei confronti dei loro figli e se anche le filastrocche venivano cantate in lingue diverse, tutte portavano con sé amore e dolcezza.
I gruppetti dei bambini in posa erano quelli dove mi nascondevo per gioco, per farmi vedere da papà e dietro i veli cremisi delle mamme negli angoli delle strade, spesso si nascondeva lo sguardo gentile della mia mamma che provava lo stesso amore incondizionato e viscerale.
Il sorriso riapparve sul viso del mio papà che dopo tanta fatica e tanta strada sembrava ringiovanito di parecchi anni. Stampava tante foto e con estrema precisione le ritagliava in tessere piccole ed irregolari. Occhi, sorrisi, riccioli biondi e morbidi come lana. La lama della forbice percorreva linee immaginarie visibili soltanto nella sua mente mentre una bocca rosa veniva estratta da una foto più grande e le sopracciglia venivano composte da decine di immagini differenti.
Sembrava in preda ad una frenesia vitale mentre la stampante lavorava incessantemente e gli anelli delle forbici gli lasciavano profondi segni rossi sulle dita ma alla fine lo scopo della sua ricerca, del suo viaggio, fu raggiunto in un senso di appagamento vibrante come una ventata di aria fresca sui panni appena lavati.
Aveva incollato al muro della stanza tutti i ritagli delle foto. Tutti i particolari e i dettagli che identificava nei volti dei bimbi incontrati nel suo cammino e nei visi delle mamme che aveva osservato con tanta attenzione. Ogni particolare occupava un posto preciso nella vastità della parete vuota che si completava come un mosaico dalle dimensioni gigantesche. Una tessera dopo l’altra fino a quando tutti quegli occhi dai colori diversi, tutti i capelli dalle mille sfumature, i tanti volti dai lineamenti differenti, diventarono un’unica grande fotografia.
Sul muro, il mosaico di una foto che ritraeva me e la mamma era apparso come per magia. I miei riccioli biondi cadevano dispettosi davanti agli occhi azzurri e vispi come solo quelli di un bimbo possono essere. La mamma mi teneva stretto in un abbraccio, poggiando la fronte sulla mia ed sorrideva. I toni della pelle, ricavati dalla pelle di altre centinaia di persone. I colori effimeri e sfuggenti degli occhi, realizzati da altrettanti occhi. Le ombre tra i capelli, sulle guance. Tutto era stato creato con una fedeltà da lasciare ammirati e stupefatti.
Mio papà si sedette sfinito ma in pace. Aveva girato il mondo intero per trovarci e ci era riuscito perché in fondo in ognuno di noi si può trovare parte dell’amore che ci rende vivi.
Sergio
Le immagini utilizzate in questo post sono state prese da Google Search Image e non è nota la presenza di eventuali copyright.